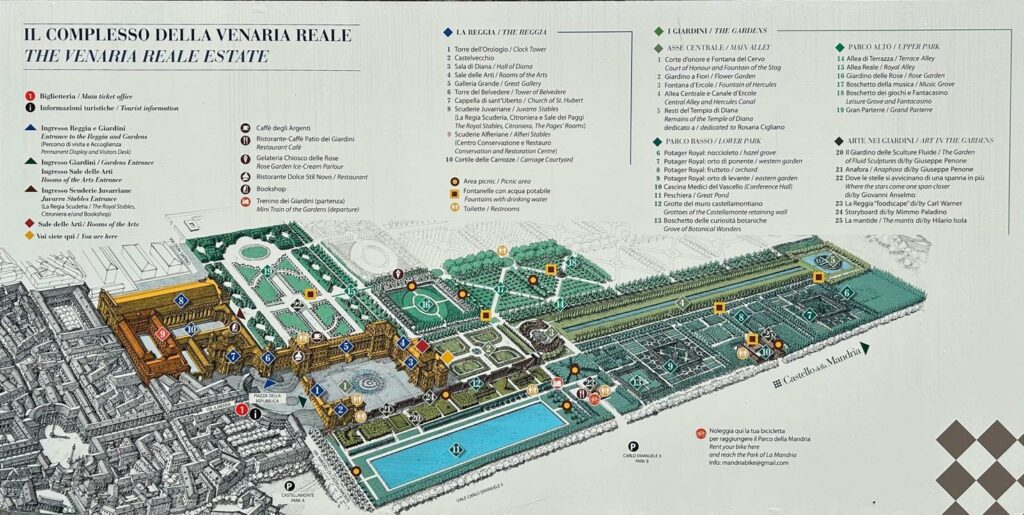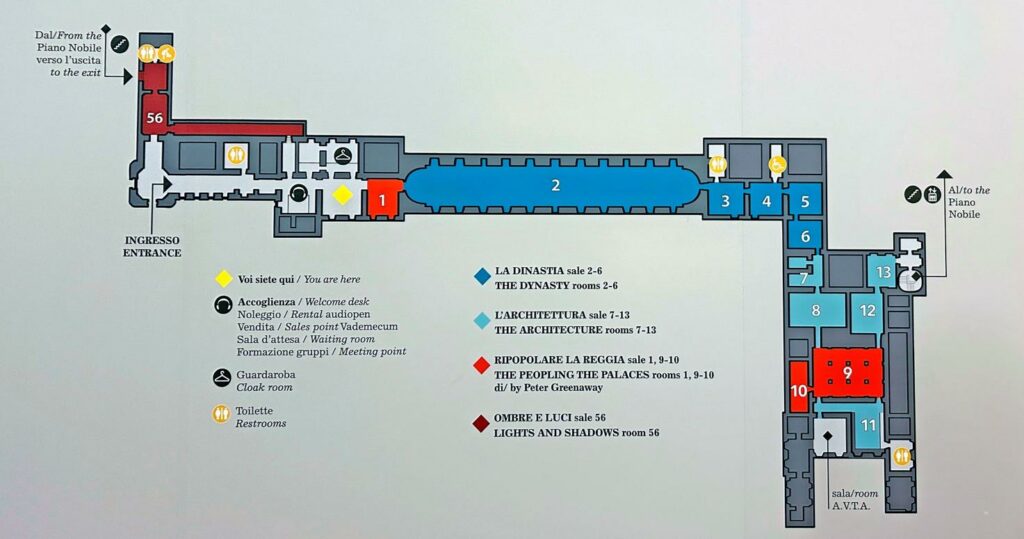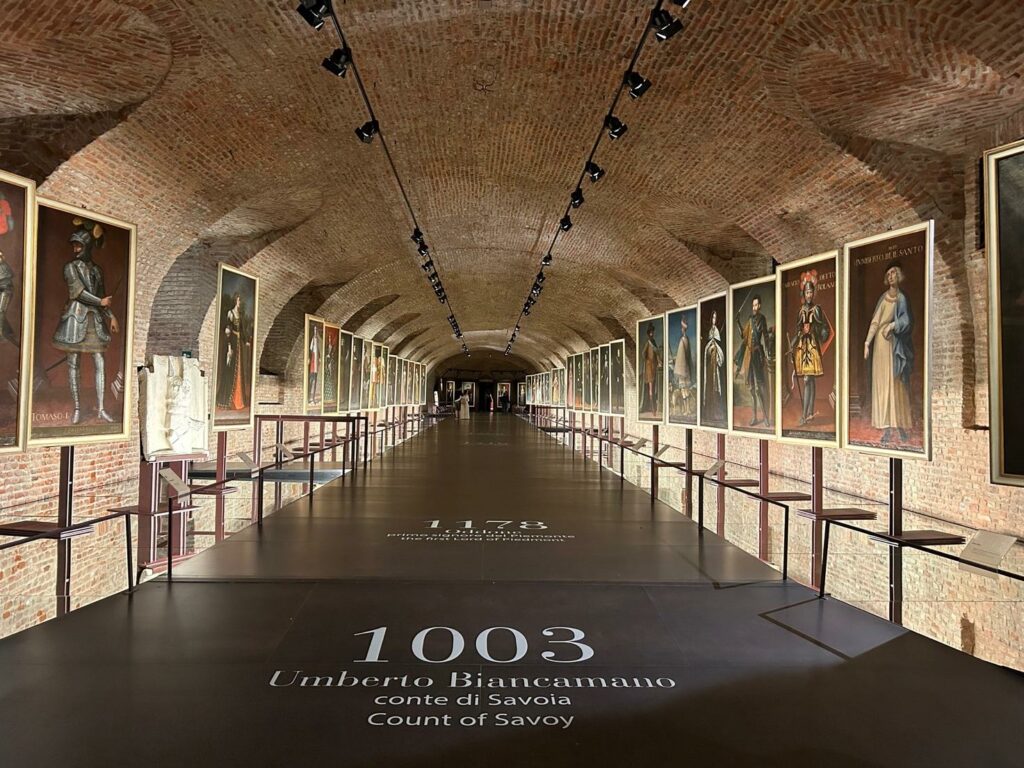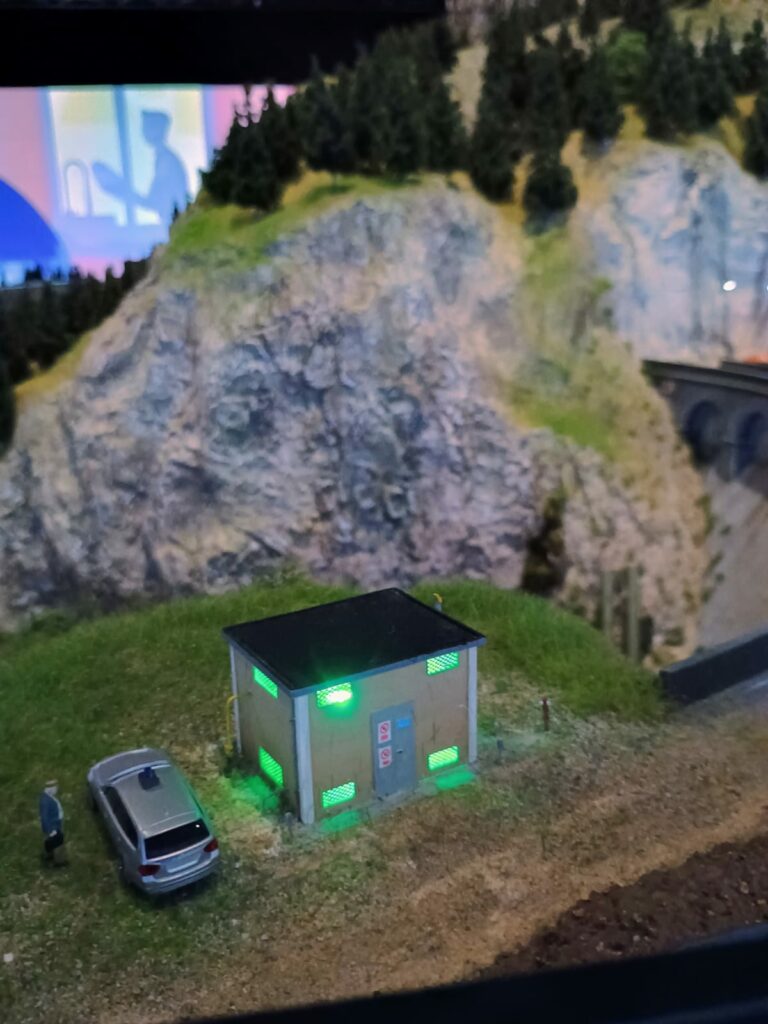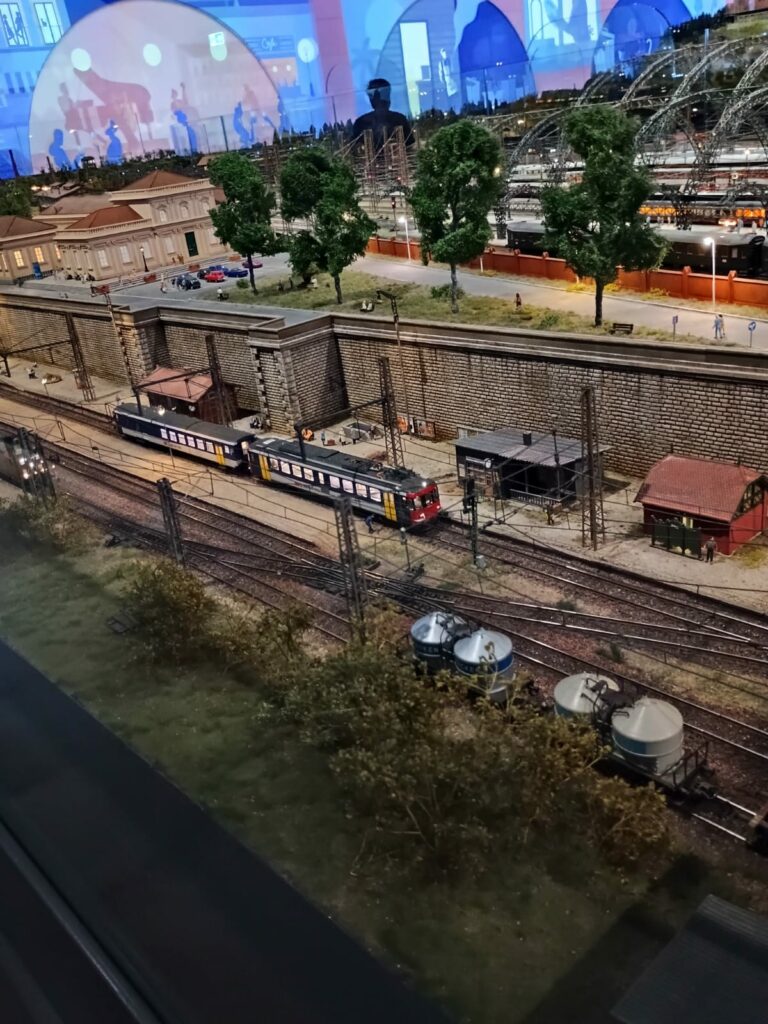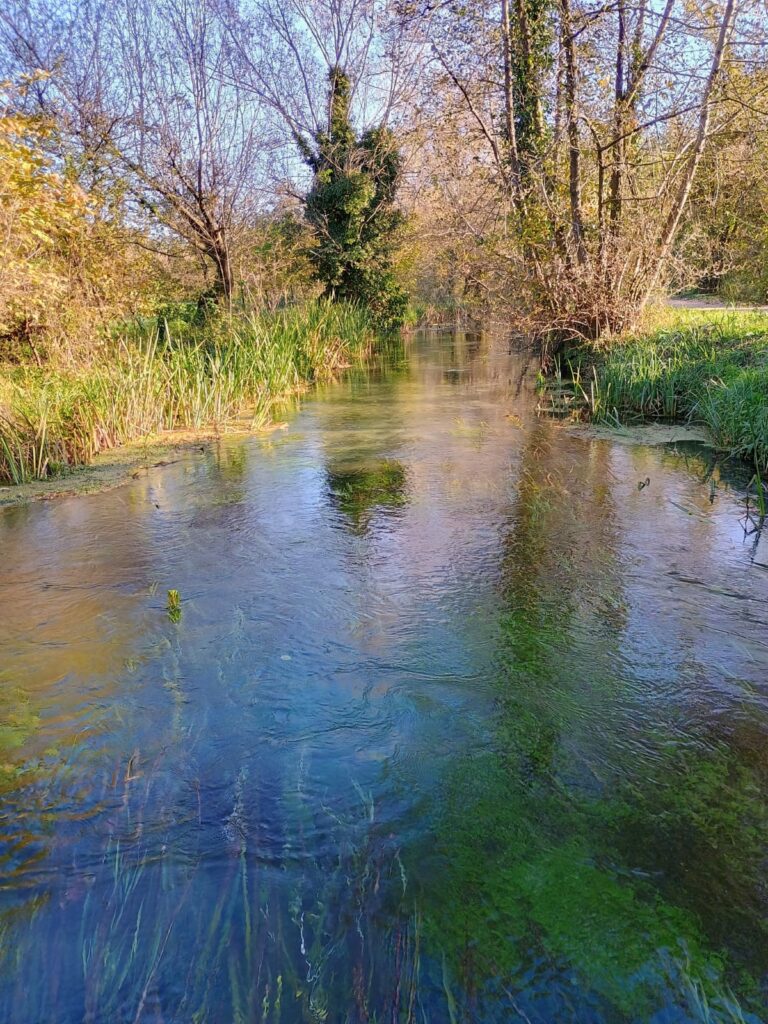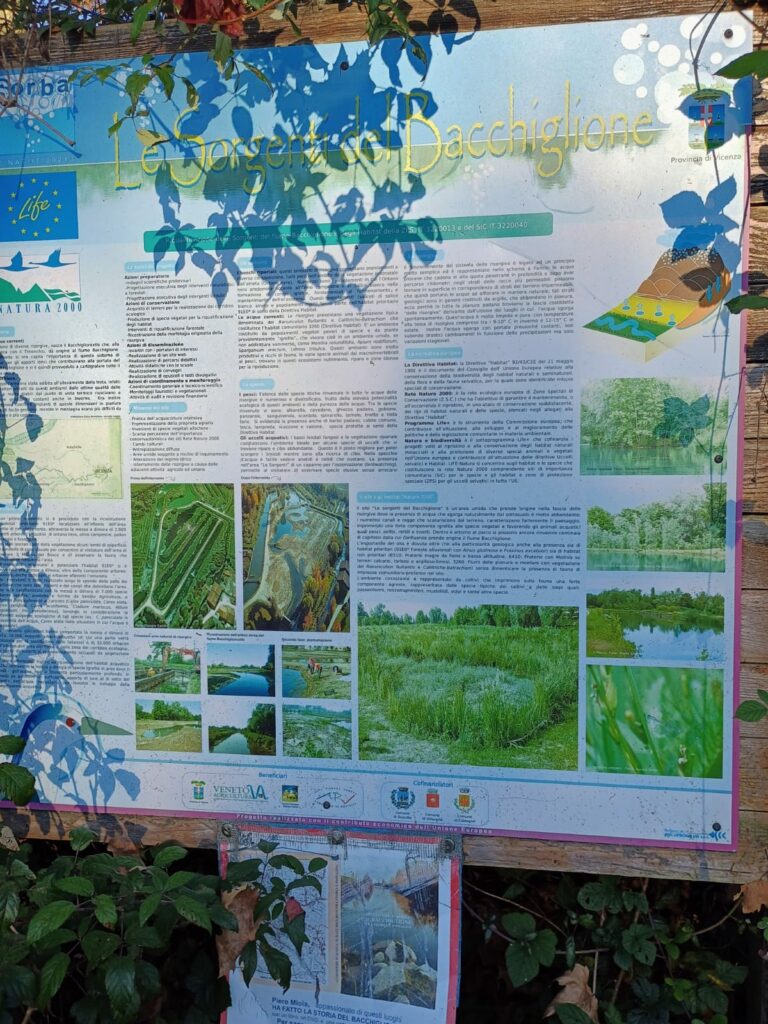Basilica di Santa Maria Novella

Un po’ di storia
La Basilica di Santa Maria Novella è una delle più importanti chiese di Firenze e sorge sull’omonima piazza. Se Santa Croce era ed è un centro antichissimo di cultura francescana e Santo Spirito ospitava l’ordine agostiniano, Santa Maria Novella era per Firenze il punto di riferimento per un altro importante ordine mendicante, i domenicani. Nel 1219 dodici domenicani arrivarono a Firenze da Bologna, seguiti da Frate Giovanni da Salerno. Nel 1221, ottennero la piccola chiesa di Santa Maria delle Vigne, così chiamata per i terreni agricoli che la circondavano (all’epoca fuori dalle mura). Questa chiesetta, di proprietà dei canonici del Duomo, era stata consacrata nel 1049 o, secondo altre fonti, nel 1094, anche se questa seconda ipotesi è più probabile, poiché nell’Archivio Capitolare della cattedrale fiorentina è conservato un documento che menziona questa data. Ad ogni modo, della chiesetta antica sono stati trovati alcuni resti sotto l’attuale sacrestia, in particolare le basi di alcuni pilastri romanici.


Nel 1242 la comunità domenicana fiorentina decise di iniziare i lavori per un nuovo e più ampio edificio, ottenendo dal papa la concessione di indulgenze per chi avesse contribuito economicamente ai lavori già a partire dal 1246. Il 18 ottobre 1279, durante la festa di San Luca, venne celebrata nella cappella Gondi la cerimonia della posa della prima pietra con la benedizione del cardinale Latino Malabranca Orsini, anche se di fatto i lavori erano già da tempo iniziati. La nuova chiesa aveva la facciata orientata verso sud. La costruzione fu completata nella metà del XIV secolo.













Il progetto, secondo fonti documentarie molto controverse[ si deve a due frati domenicani, fra’ Sisto da Firenze e fra Ristoro da Campi, ma partecipò all’edificazione anche fra’ Jacopo Passavanti, mentre il campanile e buona parte del convento si deve all’intervento immediatamente successivo di fra’ Jacopo Talenti e di Benci di Cione Dami. La chiesa, sebbene già conclusa verso la metà del Trecento con la costruzione dell’adiacente convento, fu tuttavia ufficialmente consacrata solo nel 1420 da papa Martino V che risiedeva in città.















Su commissione della famiglia Rucellai, Leon Battista Alberti disegnò il grande portale centrale, la trabeazione e il completamento superiore della facciata, in marmo bianco e verde scuro di Prato (serpentino), terminata nel 1470. Dopo il Concilio di Trento, tra il 1565 e il 1571 la chiesa fu rimaneggiata ad opera di Giorgio Vasari, con la rimozione del recinto del coro e la ricostruzione degli altari laterali, che comportò l’accorciamento delle finestre gotiche. Tra il 1575 e il 1577 fu costruita da Giovanni Antonio Dosio la cappella Gaddi. Un ulteriore rimaneggiamento si ebbe tra il 1858 e il 1860 ad opera dell’architetto Enrico Romoli.











Il primo intervento si ebbe verso il 1350, quando il registro inferiore fu ricoperto di marmi bianchi e verdi grazie ai fondi da un tale Turino del Baldese deceduto due anni prima. In quella circostanza furono fatti i sei avelli o arche tombali, i due portali laterali gotici e, forse, anche l’ornamentazione marmorea a riquadri e archetti ciechi a tutto sesto fino al primo cornicione, che assomigliano a quelli del battistero di San Giovanni. L’oculo più in alto risulta aperto dal 1367.











I lavori in seguito si interruppero e durante il Concilio di Firenze, che si tenne anche nel convento dal 1439, venne ribadita la necessità di provvedere al completamento della facciata. Solo un ventennio dopo si offrì il ricco mercante Giovanni di Paolo Rucellai, che ne affidò il progetto al suo architetto di fiducia, Leon Battista Alberti.
Note sull’accessibilità
Questa meravigliosa basilica è resa accessibile a persone con disabilità motoria attraverso l’ingresso laterale sinistro che presenta una piccolo portone e posto in fotografia.

Svoltando a destra si accede direttamente al chiostro. Il resto della Basilica è interamente accessibile, con qualche leggerissima pendenza per accedere all’interno della basilica dal chiostro.